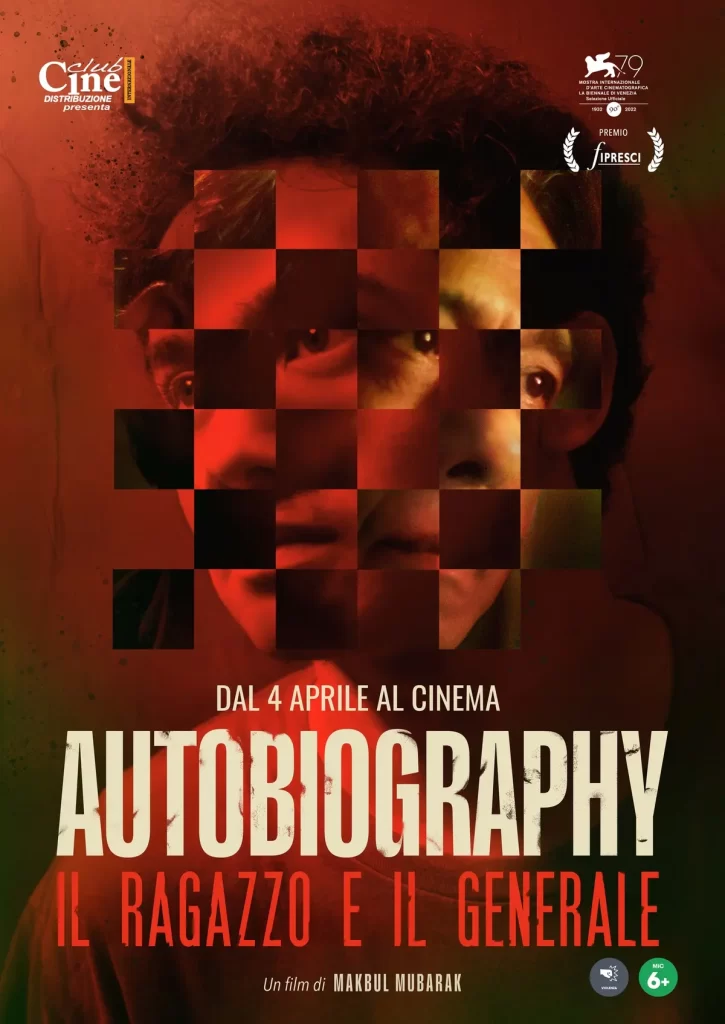La pazza gioia, ultimo film di Paolo Virzì, ci ammalia e coinvolge grazie soprattutto alle sue straordinarie interpreti, Valeria Bruni Tedeschi (Beatrice), signora decaduta dell’alta società e Micaela Ramazzotti (Donatella), fragile donna provata dalle traversie della vita, affette entrambe da disturbi mentali ed autrici di reato, ricoverate in una struttura psichiatrica.
Molto si è detto e scritto su questo film, così intenso e dai dialoghi incisivi e brillanti, in linea con la più tradizionale commedia all’italiana: la malattia mentale non solo come disagio dell’individuo ma espressione più generale di un contesto di vita che può, con le sue ambivalenze, generarla ed emarginarla.

Quello che rimane un po’ stereotipato e lontano nel tempo, è l’immagine dei servizi di cura, psichiatrici e non, che Virzì ci presenta nel suo film.
La clinica, ove le due donne sono ospiti, sembra più una comune, caotica e disorganizzata, che una comunità terapeutica: all’ingresso ci accoglie un finto cavallo, di basagliana memoria, simbolo del desiderio di libertà.
I servizi sociali, ai quali viene affidato il solo compito di controllo, vengono rappresentati da un unico operatore, relegato nel ruolo di Cassandra (per chi non la ricordasse, la mitica profetessa, figlia del re di Priamo, che preannunciava sventure senza essere creduta), che mai si confronterà direttamente con i bisogni e i desideri delle due protagoniste.

Dispiace vedere come, a fronte di un’attenzione quasi maniacale nel descrivere e rendere veritiere le diagnosi e le terapie farmacologiche di Beatrice e Donatella, non corrisponda un approfondimento dei contesti di cura. La scissione tra aiuto e controllo, tra buoni e cattivi, tra cliché desueti ed ideologici ed una contemporaneità forse ancora troppo complessa da poter (o voler) raccontare.
Sabrina Dolcini