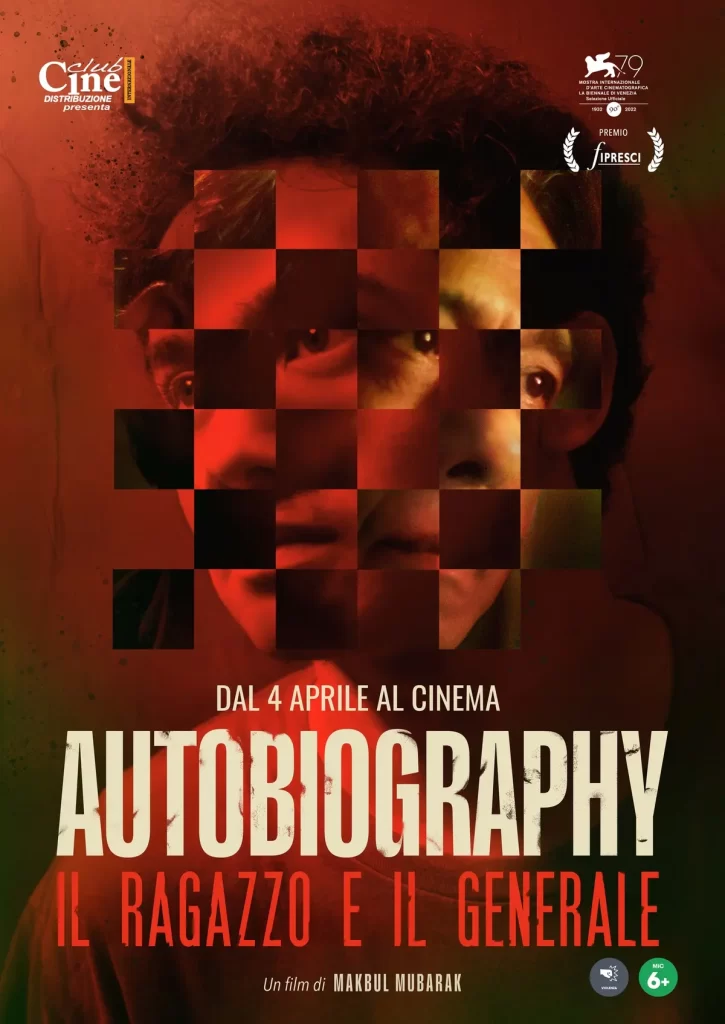Non bisogna andare al cinema prevenuti, eppure era difficile con il secondo Wolverine di James Mangold. Prima di vedere “Wolverine – L’immortale” avevo grandi aspettative dal regista di buone pellicole come “Cop Land” (1997), “Ragazze Interrotte” (1999) e “Quel Treno Per Yuma“, ma purtroppo, ammettiamolo, non fu una felice sorpresa. E’ per questo che avevo qualche perplessità nel decidere di vedere “Logan – The Wovlerine” e invece mi sarei nuovamente sbagliato ad eliminarlo dal mio carnet dei film perché è un’opera che ha il pregio di riportare dell’originalità nell’ormai ben prevedibile mondo dei personaggi Marvel.

La storia, scritta dallo stesso Mangold e sceneggiata da Scott Frank (a cui possiamo fare tanto di cappello per “Minority report“), è ambientata in un distopico futuro dove le multinazionali imperano sulla società. I mutanti sono quasi scomparsi e quelli rimasti sono anziani con gli acciacchi tipici dell’età. Logan (Hugh Jackman) vive facendo l’autista di limousine dedito all’alcool e si prende cura come può del vecchio dottor Xavier (Patrick Stewart), il quale, alle soglie della demenza senile, ha delle crisi che generano tempeste psichiche devastanti.

Finita l’epoca dei cattivi in calzamaglia e dei super eroi in tutine di latex, il cattivo è una mega company che pasticcia con i geni dei mutanti e la cui etica non prevede scrupoli nell’eliminare le cavie umane degli esperimenti meno riusciti. Ormai Logan non è più il formidabile combattente di un tempo, l’adamantio che ha nel corpo lo sta avvelenando ed i suoi poteri rigeneranti funzionano sempre meno. Il suo carattere è meno irascibile e cerca di evitare ogni coinvolgimento, ma gli eventi lo costringeranno ad una fuga attraverso il paese, dal confine messicano verso il Canada, per aiutare suo malgrado una misteriosa bambina che è scappata da un laboratorio di ricerche genetiche (Dafne Keen per la prima volta sullo schermo e della quale diremo come di tutti i bambini che sono degli attori nati).

Non c’è bisogno di conoscere il mondo Marvel per orientarsi in un film che potrebbe esserne totalmente svincolato ed ugualmente reggersi in piedi senza problemi. Gli amanti del western coglieranno immediatamente il riferimento al periodo epico e crepuscolare del genere. Un po’ come in “Quel treno per Yuma” anche in questa opera il film parte da un’atmosfera diruta e corrotta e procede verso un finale epico con un processo di redenzione e riscatto indispensabile per la ricostruzione della figura dell’eroe. La citazione esplicita è rappresentata dal film “Il cavaliere della valle solitaria” (1953) da cui Mangold trae lo speach finale di Alan Ladd al fine di utilizzarlo come emblema del film ed epitaffio dell’eroe. Un’uccisione, per qualsiasi motivo si sia verificata, è un atto moralmente inemendabile e segna l’assassino per sempre condannandolo alla segregazione dalla comunità. Infatti Shane, il cavaliere della valle solitaria, dopo aver ripristinato la giustizia nella valle, rimane macchiato dal peccato dell’omicidio e deve riprendere il suo cammino senza godere della pace che ha guadagnato per i giusti. Il parallelismo con Logan è evidente così come è evidente il comune destino con l’Ulisse della Divina Commedia che per la sua ibris non riesce a godere delle gioie della famiglia ed è spinto a ripartire per violare altri tabù. Concetto che nel film è rimarcato da Charles Xavier che ammette di anelare alle cose semplici, ad una casa ed una famiglia dove i componenti si amano , ma di non meritarlo per il male commesso in passato.

Il tema dell’etica scientifica sulla biogenetica rimane sullo sfondo e sempre presente nell’accezione ormai sdoganata sin dai tempi del “Novello Prometeo” (aka Frankenstein) della Shilley per cui la vita comunque sia creata è comunque vita e degna di amore. Il divieto ai minori di 14 anni trova fondamento nelle scene cruente di combattimento in cui finalmente è reso sul grande schermo la violenza di un personaggio che nel primo film era risultato troppo edulcorato. Gli artigli fendono, tagliano e mutilano i nemici come si suppone debbano fare. Pure al netto delle scene d’azione dovute all’audience a cui si rivolge rimane un film di spessore il cui sigillo finale è costituito dall’intensa ed esplicita canzone “The man comes around” di Johnny Cash (artista di cui Mangold fece un apprezzabilissimo film biografico nel 2005 dal titolo “Quando l’amore brucia l’anima“).