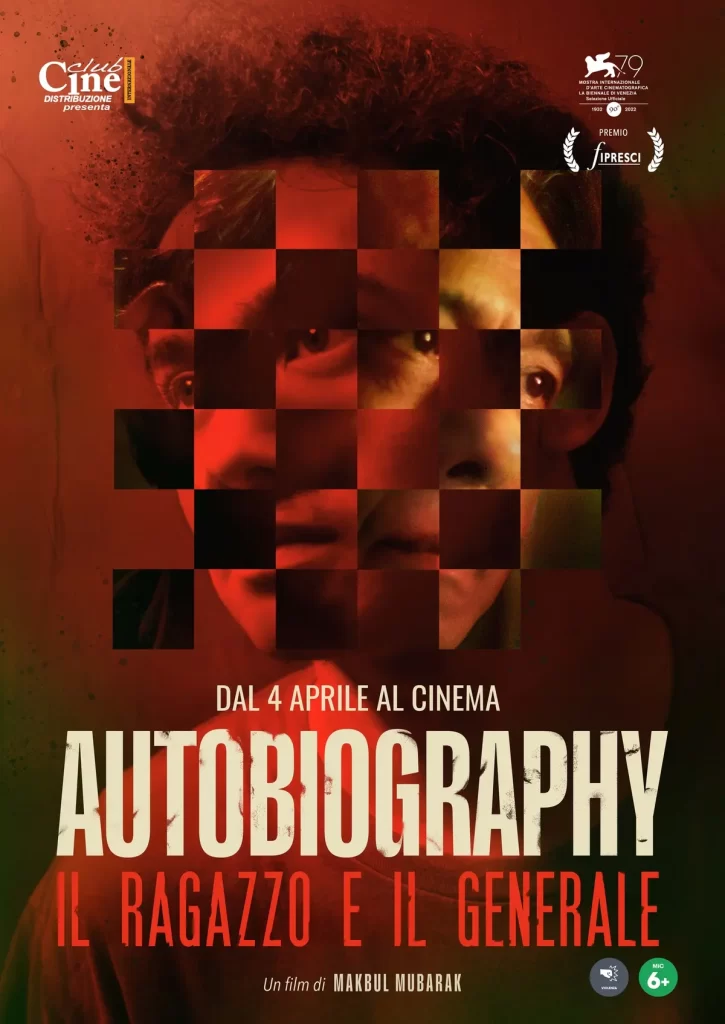Già dai tempi di Stanley Kubrick con il suo “2001 Odiessea nello spazio” si sospettava che intelligenza artificiale, viaggi interstellari e criogenia non andassero d’accordo. E’ un concetto ribadito più volte nella fantascienza sin dal primo “Alien” del 1979 e fino al recente “Passengers” di Morten Tyldum. Di astronavi in orbita impossibilitate di comunicare con la squadra a terra a causa di mille disgrazie ed avarie, mentre i poveretti laggiù sono in gravi ambasce e con i minuti contati, ne abbiamo visti a iosa, tanto che sarebbe noioso elencarli, ma quello di cui veramente non se ne può più è la scampagnata nel bosco dove un orribile pericolo fa fuori tutti i partecipanti uno ad uno.

Una volta tarato sullo zero pressoché assoluto lo strumento che misura la credibilità di un film sul precedente “Prometheus“, questo ultimo lavoro di Ridely Scott segna comunque un movimento verso l’alto e lo si deve ad una circolarità nella trama della intera saga, che chiude un anello anticipato, se non proprio iniziato, nello storico “Alien” e che riguarda il rapporto tra creato, creatura e creatore. Non sveliamo nulla poiché è già tutto chiaro nella sequenza iniziale, un flashback dove l’androide David (Michael Fassbender), già presene in “Prometheus“, dialoga con il suo ideatore Michael Wayland (Guy Pearce) prima che tutto abbia inizio. In questo dialogo c’è la chiave del film e di tutta la saga. Vi si riscontrano elementi archetipici del tema di Prometeo, per l’appunto, ma anche di Zeus e Cronos. La peritura sostanza del potere ben riassunta nel poema di Shelley “Ozymandyas” contrapposta alla hybris di chi si paragona ad un dio, arrogandosi il più grande degli attributi: quello della creazione. Non è quindi per caso che appena “attivato”, l’androide David, dopo una rapida e profonda riflessione, accenna al pianoforte “L’entrata degli dei nel Walhalla” dal “Rehingold” di Wagner. Si tratta proprio del “Crepuscolo degli dei”, che anticipa il vero e proprio Götterdämmerung che si sta per compiere. Ma le note della celebre sinfonia eseguite al pianoforte mancano di spessore senza l’impatto dell’orchestra e ne risulta quindi solo una pallida imitazione, come altrettanto mancante si rivelerà l’opera dell’androide. Nel rapporto tra l’androide e Wayland si manifestano subito le incongruenze di status ed è qui apprezzato dai cultori della fantascienza il chiaro riferimento ad Isaac Asimov ed alle sue tre leggi della robotica.

Per anni i creazionisti hanno sostenuto che un organo così sofisticato come l’occhio umano non poteva essersi sviluppato per caso, ma necessitava invece dell’opera di un creatore (si veda invece a confutazione il libro “Alla conquista del monte improbabile” di Richard Dawkins) ed in tal prospettiva va interpretato il primo fotogramma del film che ritrae l’occhio di David dal quale la prima cosa che vede è la luce in una metafora neanche troppo sofisticata. Lo stesso nome dell’androide è un nome biblico di colui che sfidò il gigante Golia e che divenne re. Il riferimento al dio creatore è rafforzato dal titolo stesso “Covenant“, che è il nome della nave spaziale e che in campo biblico esprime il concetto di “patto con dio” ed infatti è funzionale a sottolineare questa implicazione che a capo della spedizione si ritrovi un uomo di fede, contrapposto al “sintetico” Walter che si occupa ed affianca l’equipaggio umano nella missione non per amore ma per dovere. L’origine della vita ed il suo scopo sono in definitiva il lodevole e sempre interessante tema centrale del film, che purtroppo aleggia per aria senza essere mai veramente approfondito.

Oneste le scenografie, anche se ci si sarebbe aspettato qualcosa di più soprattutto relativamente all’astronave ed i suoi ambienti. La prima sembra riciclata dalla serie televisiva degli anni 70 “Spazio 1999″ ed i secondi peccano di un guizzo originale. Mentre è di sicuro impatto, anche se forse un po’ gigionesca, la città aliena. Al netto dei cliché del genere, che vengono religiosamente ripercorsi senza alcuna esclusione (c’è pure il malato che interrogato sulla sua salute asserisce eroicamente di stare bene), si assiste ad una recitazione decorosa e professionale anche se minata da una sceneggiatura che fa acqua come un colabrodo. Il cast è così politically correct da includere non solo una copia omosessuale, ma anche una copia interraziale, con tanto di scena di sesso in doccia inclusa, per buona pace di chi già incominciava a sentire la mancanza di Charlize Theron.

Alla fine della proiezione rimane il grattacapo di capire come farà Scott nel terzo episodio a ricollegarsi con il film del 1979. Ad essere ottimisti si tratterà di un colpo da maestro con cui si riscatteranno i primi due brutti tentativi di questa trilogia e si spiegheranno molte incongruenze e curiosità (incluso il cameo di James Franco all’inizio del film), ciò a patto però che si rivedano una buona volta le procedure di atterraggio ed esplorazione di pianeti alieni a vantaggio della credibilità della pellicola. Altrimenti il passo del poema di Shelley «Sono Ozymandyas, il re dei re. Se qualcuno vuole sapere quanto grande io sia e dove giaccio, superi qualcuna delle mie imprese», rischia di essere un compito veramente poco sfidante. Intanto proliferano su you tube le speculazioni su che fine a fatto il personaggio di Elisabeth Shaw, sul perché David abbia ucciso l’ingegnere alieno e perché mai le astronavi debbano avere quell’irritante voce calma e rassicurante anche quando tutto va a rotoli.

Di base ci sentiamo di raccomandare quanto detto in occasione della recensione di “Life”. Se sbarcaste su di un pianeta ad anni luce dalla terra da cui trasmettono “Take me home country road” di John Denver e, come se ciò non bastasse a mettervi sul chi vive, trovaste qualcosa di strano per terra, in una caverna o in un antica necropoli, qualunque cosa sia: è meglio non toccare.