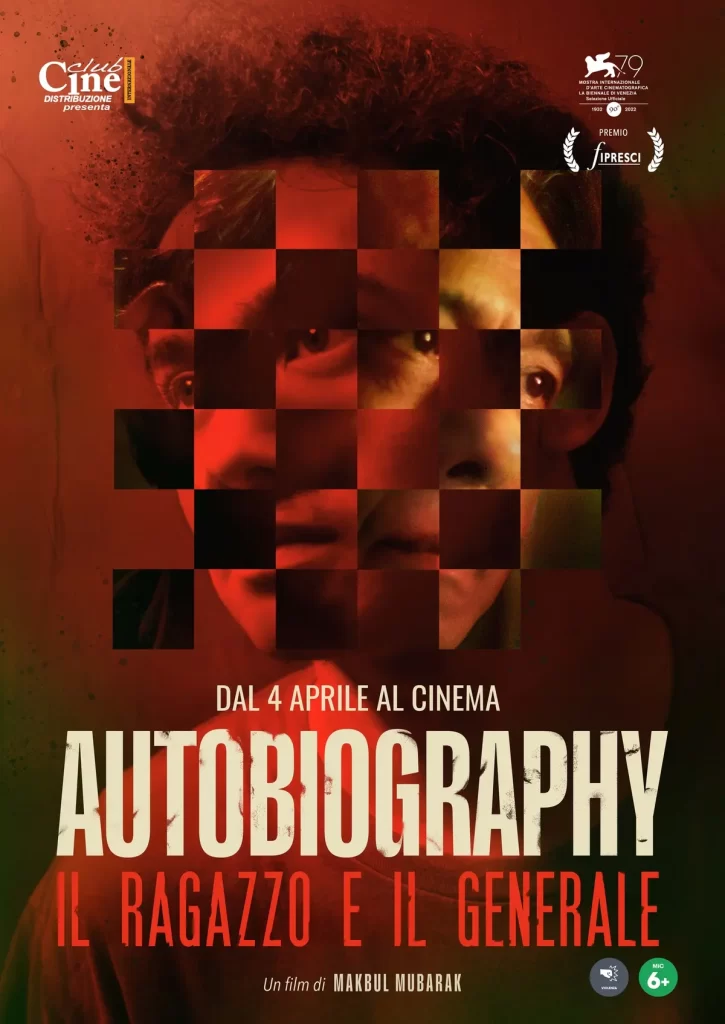Se nel 1954 la laguna nella quale sguazzava l’uomo-pesce, il Gill-Man di Jack Arnold, era ancora nera e imbevuta dei brividi e dei terrori abissali tipici di un regime notturno dell’acqua, con “Shape of Water” invece – equorea ascesi del meraviglioso, romantica “stinfalizzazione” del perturbante natatorio, ittico gemitio del thaumazein – l’acqua si fa dolce e smeraldina. “Chora” amniotica, informe materia imenaica, l’acqua riceve, nelle fluide alcove di goccia dei suoi volumi, l’impronta di un bacio: di una storia d’amore inconchigliata nel glauco “viridarium” del colore di Venere. La storia del film, calata nel globo vetroso, deformato, di un acquario favolistico, è di una semplicità disarmante. Siamo a Baltimora nei primi anni ’60, in piena Guerra Fredda, in un mondo polarizzato dai blocchi contrapposti di USA e URSS. Un bel dì, in un laboratorio militare dove si conducono esperimenti segretissimi, fa la sua comparsa una creatura acquatica metà uomo e metà pesce. Una strana creatura intelligente pescata non si sa come nei fiumi dell’Amazzonia. Poi c’è lei, una donna delle pulizie: muta, gracile, ossuta, cavallina; fasciata nella livrea di un camice da lavoro verdino, memore forse della pelle di un rettile, o di un pesce: profana Melusina delle pulizie armata di scopa in sterquilino incognito. La donna si innamora della creatura e la creatura della donna. Questo è quanto. Inno alla settima arte, film manifesto di una passione cinefila “La forma dell’acqua” segna il punto d’arrivo di una lenta, ma inesorabile carriera del regista nelle piantagioni dell’immaginario più sontuoso. Nella fenomenologia erotica di Guillermo del Toro l’amore è un fiore di loto, l’escrescenza perlifera del mostruoso. La polarità di Eros e Thanatos si completa nel teratos di una bestialità che si fa acquatica, sponsalizia: nubile precondizione alla diade del proprio imenaico godimento. La favola dell’uomo-pesce, questo Oannes messicano, sensibile tritone di dianoetica virtus a tendenza taumaturgico-rigenerativa, affonda le radici tanto nei miti quanto nella biologia. In parte guaritore, in parte eroe civilizzatore, ne ritroviamo i lacerti un po’ ovunque nel mondo; in Grecia egli è Cecrope ed Erittonio, Colapesce in Italia, Dagan in Mesopotamia, Vishap in Armenia, Fu Hsi in Cina, Nammo presso i Dogon: in Messico invece prolifera in granulare grumo di storioniche uova nei nomi di Atlahua, Chalchiuhtlatonal, Winac-car…
Ma l’associazione del pesce con la sapienza e col divino non è sfuggita nemmeno al Cristianesimo che fa dell’ichthys il proprio simbolo primevo, e della foggia dei vescovi degli uomini-pesce mitriati; incalzando infine il “pesce” fino all’espressione di giubilo di “Osanna!”: ombra di Oannes.
Egli è l’axolotl: il prodigioso anfibio neotenico divinizzato dai popoli precolombiani. Diafano e candido come un bimbo senile, satollo della fluviale poppata, esso – miracolo della natura – può rigenerare da sé i suoi organi, proprio come la creatura del film. L’amazzonico anfibio è una creatura metaforica; fa pendant con l’ittioide vittoriano occultista Abe Sapiens, già apparso nella masnada mutante di Hellboy, suo grafico preludio. Le squame ganoidi, di malinconica, e “mal iconica” proscrizione, sono embricate da strati e strati di fotogrammi di celluloide.
Film nostalgico nel senso che vive di nostalgie, di crisi, tempi e controtempi, “La forma dell’acqua” fa agire, in parabola, una dialettica massmediale tra cinema, televisione e pubblicità. È il declino scalare del cinema e dell’arte nelle tube del catodico e nelle matrici del seriale. Sulla pelle emulsionale – palpitante vene e luci bluastre -gatteggiante iridescenze cristiche, dell’uomo-pesce a sua volta pescato dalla modernità tecnocratica, si apre una ferita; è la poesia del cinema stesso a sanguinare; minacciata dalla prosaicità consumistica della montante era della televisione, che del cinema sembrerebbe essere la perversione su scala domestica. Al di là degli ovvi significati politico-sociali – l’omosessualità, il razzismo, la Guerra Fredda, il KGB – il film sfrutta il tema del “diverso” per farne metafora di metafora: una metafora di secondo grado che nulla ha che fare con l’ovvietà dei significati letterali della storia: con la fermentazione di banalità politico-sociali che le crescono addosso come un guanto di muffa. Guillermo del Toro non è Ken Loach. Piuttosto è il Pancho Villa di un’improbabile rivoluzione del mostruoso, uno Zorro del macabro, un cacicco del fantasy: ultimo fazendero del fantastico dopo la generazione dei Chano Urueta, Fernando Mendez e Rafael Baledon. Il cinema è sogno, immaginazione, magia. A del Toro poco interessa denunciare col cinema le ingiustizie sociali anche quando sembra che lo faccia: l’indignazione storica, al massimo, può essere un pretesto per dare intensità e forza emotiva alle sue favole dark. Ma è comunque alla greppia del fantastico più semplice e puro che Guillermo del Toro lega le mandrie lovecraftiane delle sue storie. Nel “Labirinto del Fauno” di certo non ci voleva raccontare uno spaccato della Spagna franchista, come pure le tragedie della guerra civile spagnola ne “La spina del diavolo”. Tutto è simbolo. Il mutismo, l’afonia, la privazione della voce di Elisa ad esempio, non è qui referto nosocomiale, dato di menomazione, bensì puntuale indizio. Una ben precisa scelta programmatica, uno scarto a favore della visione, del visibile: dell’apparizione dell’idea. La voce, strumento accessorio di significazione, è esclusa dai circuiti referenziali a tutto vantaggio di una tavolozza immaginifica incrostata di occhi, luce e colore. In pratica siamo nel regno del cinematografo, così com’era cominciato, specie con Méliès: una lanterna magica, una fantasmagoria. Elisa Esposito, nomen omen, ha in comune con la creatura squamosa un’araldica dell’acqua, una genealogia dell’onda e del flutto; un’origine diluviana concretizzata nell’oblazione trofica, nella xenìa di un uovo, “vesica piscis”, strenna di tuorlo e di guscio, regalo d’amore, che conta come il recupero di un legame ancestrale. Orfana, abbandonata alle acque alla nascita, è essa stessa, Elisa, una creatura acquatica, segnata, graffiata, eppure in promessa di branchia per merenda d’amore. Ondina, Madonna dell’Ovo, Anfitrite dell’igiene, esorcista della sporcizia, clarissa di spugna, Elisa è tratta dai tiberini gorghi portuali di Baltimora; ella è romulina salvata dalle acque, dunque ninfa mosaica, in sospetto di Musa, senz’altro Musa di mimica, elingue Lara dal chitone di alga, sacerdotessa di vasca, di secchio, straccio e ramazza; segaligna ninfa crenea; è Ofelia che annega nelle chiome delle proprie acque d’amore. La psicologia dell’acqua, quella gora che prima ristagna nei secchi di Elisa per invadere poi i locali del bagno e straripare infine, percolando a diluvio, nella sottostante sala del cinematografo, viene privata da un’intenzione profana di lavacro, di abluzione, per essere accesa di ben altra virtù ascensionale. L’acqua diviene l’elemento dell’amore e del sogno: la gravità delle convenzioni sociali è addormentata, invertita sotto la spinta di eros; dove un vestito rosso può persino diventare il flammeum fluttuante di una sposa atlantidea e legarsi per analogia fluviale ad ulteriori fantasticherie cinefile, e fare di Elisa Esposito una solidale ipostasi di Juliette/Dita Parlo: sposa epifanica nelle sommerse visioni de “L’Atalante” di Jean Vigo.
Trovare una forma dell’acqua, dare una forma all’acqua equivale alla quadratura del cerchio: una sfida ai confini dell’ossimoro. Possiamo dire che il genio di Guillermo del Toro vi sia riuscito in pieno. Il burattinaio messicano di mostri, questo Rabelais in salsa guacamole, Bosch azteco, ha fatto centro realizzando un’opera di incomparabile lirismo: una favola d’amore semplicissima nel volume dei suoi depositi narrativi, e al contempo complessa per le risonanze mitogene che da essa si irradiano.
Ma qual è il senso di questa fiaba?
Nell’impennare tale acuzie di spine e di pinne e di branchie, del Toro ci manifesta una nostalgia filmica di epoche mitiche – le cadillac, il musical, il cinema fantascientifico dei drive in – confezionando una féerie de rêve, un tableau weird sulla taglia di una cultura popolare abbigliata di sogni ed evasione, a compiacere un intrattenimento perduto. L’estetica del film, le fonti iconografiche cui il regista voracemente ammicca, e attinge, per visiva gestazione, sono le copertine delle riviste pulp dell’epoca, gli Amazing Stories, i Black Mask e i Flying Aces, i Thrilling Wonder Stories e i Weird Tales naturalmente: meraviglie dell’editoria popolar-psicotronica, calepini del kitsch, serializzati saltèri del camp, del pastiche e del bizzarro, illustrati con grafico vigore da artisti come Margaret Brundage, Virgin Finlay, Norman Saunders, Earle K. Bergey e Hannes Bok. La storicità visionaria di Guillermo del Toro giunge qui all’auto-trasparenza assoluta: all’atto puro finale di quel divenire dialettico del cinema in seno al concetto di “mostruoso”. Un traguardo che cancella, negandolo, il confine tra il narratore e il narrato, rimuovendo il limite tra l’oggetto fantastico e il mezzo deputato ad esprimerlo. Non ci sono dunque film di mostri. Per Guillermo del Toro il cinema stesso è un mostro: sgocciolante araldo di metaforica corporatura, un monstrum di prodigio etimologico, ostentum ossequioso e Ossequente. La creatura predilige da sempre il côté del visibile, emergendo fin dall’inizio dal mito solo per mostrare se stesso in quanto cinema. A Guillermo del Toro sono sempre piaciuti i mostri; la sua galleria di strane creature farebbe invidia al “Physiologus” o al bestiario medievale di “Aberdeen”. Col suo cinema del Toro ci ha fatto amare emofagi ragni meccanici di alchemica fattura, mimetici lepidotteri assassini; e ancora: anneriti spettri combusti, glabri lemuri chiroftalmi, fauni ammonici, golem dorati, uomini di fumo in scafandro palombaroide, colossali poseidonici kaijū degli abissi, sadici manichini di nazisti meccanizzati, fino a Red, il più simpatico di tutti: quel diaboliforme cerambice color cremisi, Cernunnos scornato e rutilante che tanto filo da torcere darà alle forze del male in rima di assalto.
Solo che questa volta l’enciclopedismo teratologico ha trovato una felice sintesi aggiungendo una voce lirica all’inventario del “mostrificabile”.
Se per Talete, il filosofo di Mileto, l’acqua è origine e modello di ogni cosa in natura, tuttavia parlare di una “forma” dell’acqua, al di fuori della filosofia e della scienza, era un’impresa che poteva riuscire solo alla poesia: libera com’è di unire gli opposti. E se l’acqua è senza dubbio l’elemento d’elezione per veicolare la poesia nei suoi aspetti più puri e simbolicamente primigenii; allora, con “La forma dell’acqua”, con questo semplice film di mostri, Guillermo del Toro ha dimostrato che l’impresa di fare poesia talvolta, seppur raramente, può riuscire anche al cinema.
Federico M. Monti