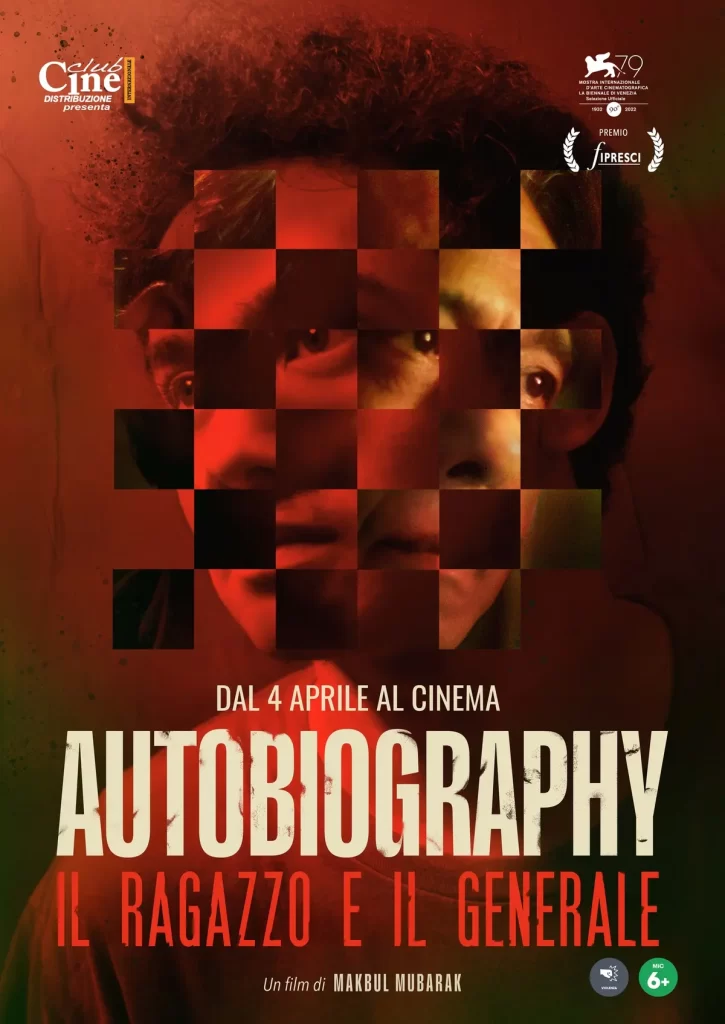Giappone, 2037. L’influenza canina infetta i cani di Megasaky City. La minaccia di un contagio umano è elevata. Il sindaco Kobayashi ordina l’esilio degli animali su un’isola di rifiuti ai confini della città. Il piccolo Atari, nipote del primo cittadino, parte alla volta della discarica marina, dove, assieme ad un branco di nuovi amici a quattro zampe, si mette alla ricerca di Spot, il suo cane-guardia.

Nei manuali di storia del cinema, gli epigoni di D. Bordwell ricorderanno il primo ventennio degli anni ‘00 per la diffusione capillare del cinema d’animazione. Grazie all’affrancamento del genere dalla mera produzione di film per famiglie, le pellicole animate hanno rappresentato l’espressione cinematografica più prolifica, creativa e innovativa dei primi decenni del XXI secolo – da “Strings” di Rønnow-Klarlund(2004) a “Coraline e la porta magica” di H. Selick (2009); da “Wolf Children” di M. Hosoda (2012) a “Your Name” di M. Shinkai (2017).

Non è un caso, quindi, che uno dei maestri del cinema contemporaneo si sia (ri)avvicinato a questa pratica – ed è in buona compagnia, si veda, per esempio, G. Verbinski con “Rango”(2011).
Dopo “Fantastic Mr. Fox” (2009), Wes Anderson (fresco vincitore dell’Orso d’argento per la miglior regia) torna alla tecnica dello stop-motion– resa famosa dalla Aardman Animations–, riversando il suo inconfondibile tocco naïf ed eccentrico nei personaggi di plastilina sullo schermo. Ogni fotogramma è un tripudio di estro e fantasia, di gioco e di colore – si veda la riunione canina nel bunker di fondi di bottiglia. C’è un godimento fanciullesco nel film – che aveva toccato l’apice in “Panico al villaggio” di S. Aubier e V. Patar (2009) –; sapientemente stemperato, però, dalla perfezione geometrica della messa in quadro. Anderson è un architetto delle immagini. Ogni particolare è studiato nei minimi dettagli: le linee spezzate dei movimenti di macchina, i décadrage, la costruzione simmetrica dell’inquadratura, la profondità di campo occupata da elementi narrativi –si osservi, a tal proposito, la prima sosta del viaggio di Atari, dove il regista suggerisce ed anticipa, attraverso una fotografia, il rapporto tra Spot e Chief.

Diviso in capitoli teatrali ispirati alla tradizionale nipponica – i protagonisti assomigliano alle marionette del Bunraku –, scandito dal battito dei Taiko (si veda l’incipit), il racconto mette in scena una distopia canina in cui i personaggi a quattro zampe lottano per la loro libertà, alla riscoperta dell’amore per i propri padroni. Non solo, la struttura narrativa strizza l’occhio alla filmografia dello stesso Anderson – “Le avventure acquatiche di Steve Zissou” (2004) –, con un personaggio guida, Atari, che ci porta alla scoperta di un mondo isolato, l’isola dei cani – reificazione del “muro” trumpiano.

La maniacale ricerca visiva del cineasta texano però non può che togliere spazio alla storia, subordinandola all’impianto visivo, prepotentemente influenzato dal cinema e dalla pittura del Sol levante. Lo stile Ukiyo-e – il personaggio del maggiordomo appare come una versione raggrinzita de “L’attore” di T. Sharaku –, l’immaginario post-apocalittico Kaiju, le lezioni dei maestri Mizoguchi – si pensi alla leggerezza condivisa con I” racconti della luna pallida d’agosto” (1953) – e Kurosawa – la tavolozza dei colori di “Kagemusha – l’ombra del guerriero” (1980) o la prossemica samurai in “Sanjuro” (1962) – danno vita ad una stile animato che “azzanna” la vista dello spettatore, lasciandolo senza fiato, come Atari di fronte al matrimonio canino celebrato tra un animale e il suo padrone.
Alessio Romagnoli