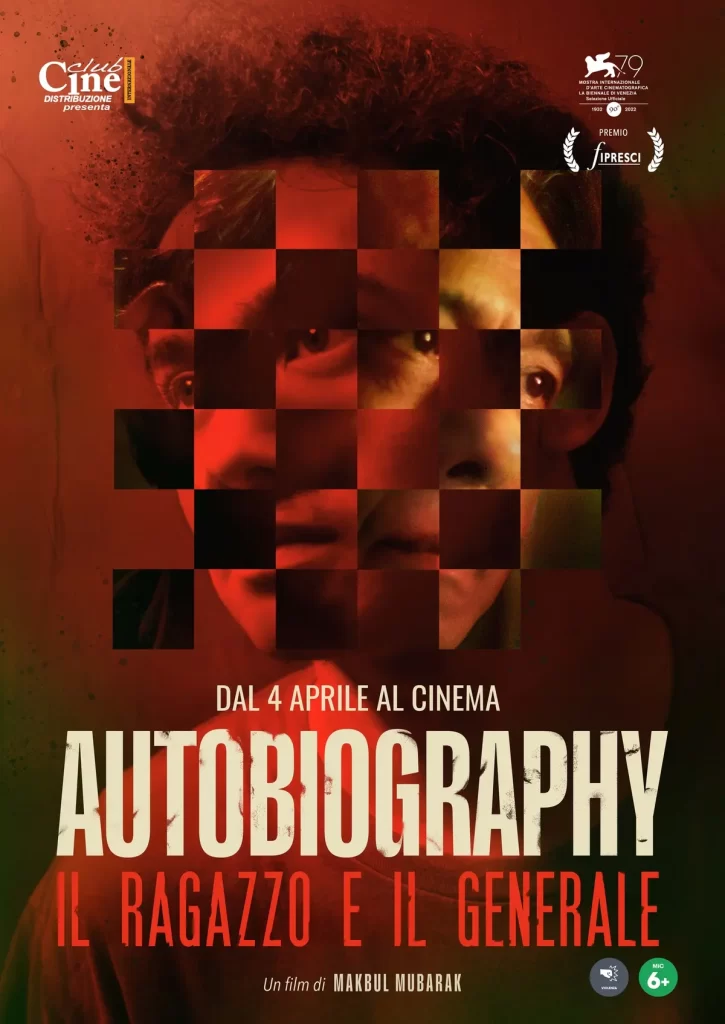La Cinematheque di Miami Beach (1130 Washington Ave) è forse la sala cinematografica più accogliente che conosco. Avrà al massimo sessanta/settanta posti. Una pianta irregolare, con una specie di corridoio aperto che le gira intorno e permette al pubblico di passare dietro lo schermo, seguendo un percorso di manifesti, fotografie, oggetti e libri… sempre interessanti per curiosare un po’ in attesa del film. Ci sono andato diverse volte negli ultimi due anni, da quando ho iniziato a frequentare assiduamente Miami, e la speciale atmosfera che si respira, un po’ retrò, è perfetta in quella miniatura che ti fa sentire fuori dal tempo. E’ uno spazio sospeso, e la visione di un film si arricchisce di quello che il “contenitore”, come un velo discreto e avvolgente, aggiunge all’abituale magia della proiezione in sala per un gruppo di sconosciuti che hanno scelto di assistere allo stesso spettacolo.

La selezione è tipicamente “art house”: in quel cinema ho sempre visto dei film interessati ma l’ultimo è stato davvero sorprendete. La sorpresa deve venire anche dal fatto che si tratta di un film iraniano, prodotto di un altro mondo quindi, di un’altra cultura, di una diversa sensibilità.
“The Salesman” di Asghar Farhadi, premio Oscar come miglior film straniero 2017. Il regista non è andato a Los Angeles a ritirarlo per protesta contro il provvedimento del governo Trump che vuole limitare l’ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di sette stati considerati ad alto rischio terrorismo, tra i quali appunto l’Iran. Durante la premiazione degli Oscar, in un clima un po’ radical chic e militante, decisamente critico verso il neo eletto Presidente, Farhadi ha affidato a una lettera le sue rimostranze, ricevendo la prevedibile ovazione della sala.

Il film è straordinario nella sua esotica semplicità. Emad insegna in un liceo, ma è anche un attore di teatro piuttosto apprezzato. Lui e la moglie Rana sono i protagonisti di “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller, che una compagnia teatrale sta mettendo in scena.
Costretti ad abbandonare il loro appartamento per un cedimento strutturale del palazzo, trovano una soluzione abitativa temporanea grazie a un collega, e si trasferiscono in un altro quartiere di Teheran. Per un errore di persona, Rana, mentre sta facendo la doccia, viene aggredita da un vecchio cliente/amante della precedete inquilina, una donna di facili costumi..

Emad non vuole coinvolgere la polizia e inizia una sua indagine personale che lo porta a scoprire il colpevole in un finale carico di tensione, sorprendete per il movimento tellurico dei sentimenti dei tre protagonisti.
Con pochi mezzi, senza effetti speciali, affidandosi solo a una grande scrittura e un gruppo di bravi attori, Farhadi conduce il pubblico nel suo gioco perfetto. La storia si muove con passo lento, ma con un ritmo emotivo incalzante che non da tregua. Significativo il fatto che scelga Rana quale depositaria di un’istintiva saggezza e umanità, di una superiorità morale: davanti al suo assalitore, umiliato e vinto, lei sola è capace di perdonare, mentre il marito, accecato dal rancore, non vede al di la del suo naso.

Il colpevole, un uomo anziano e malato, è certamente un essere meschino ma è anche vittima del caso e della sua stessa debolezza. Le scuse che rivolge a Rana sono sincere, ma solo lei è in grado di leggere la sua disperazione, il terrore di perdere la faccia davanti alla sua famiglia per gli atti indegni che ha commesso, per la sua pochezza umana. La donna, in quel momento drammatico, non può che provare dell’affetto per lui e tendergli la mano con una carità che nel nostro mondo potremmo banalmente definire “cristiana”, ma è invece qualcosa di universale che convive in ogni essere umano con gli istinti più feroci. Questo movimento di sentimenti, contrastanti e contrastati, è davvero commovente.
Il film di Farhadi rimane nell’animo e ogni tanto riaffiora, per associazione, per similitudine, o per contrasto. Mi è tornato in mente pochi giorni fa, dopo un paio di mesi, quando meno me lo aspettavo.

Era un po’ di tempo che avevo la curiosità di vedere dal vivo un’opera realizzata da Daniele Puppi a Milano, a casa di una coppia di collezionisti.
Ho conosciuto Daniele a Roma nel 2006 per scoprire che eravamo cresciuti a pochi chilometri di distanza in due paesi del Friuli, in provincia di Pordenone. Negli anni a seguire siamo diventati amici, abbiamo iniziato a collaborare ogni volta che si sia presentata un’occasione e ci teniamo informati sulle novità delle nostre vite e del lavoro. Sicuramente siamo dei “compagni di viaggio”, una tipologia speciale di amici, particolarmente preziosa, che non da mai niente per scontato ma non ha bisogno di conferme. Esiste una parola turca che sintetizza questo concetto: DOST. Nel mondo posso contare su una piccola rete molto selezionata di “dost” che “camminano con me” appunto. Daniele è uno di loro.

L’opera che sono andato a vedere a Milano è stata realizzata su commissione, in uno spazio molto preciso: l’ingresso di un grande appartamento del centro, dove vivono Franco Tatò e sua moglie Sonia Raule. Sapendo che presto sarei andato a Milano, Daniele ha chiesto a Sonia se potevo passare a vedere la sua opera. Per un altro caso della vita (o per un’ennesima conferma della teoria dei “sei gradi di separazione”) quando ancora non conoscevo Daniele, avevo già incontrato Sonia a Roma, attraverso un comune amico che ha avuto un’importanza notevole per entrambi. Un altro “dost”, che purtroppo ha concluso la sua vita nel giungo del 2005. E’ con lui che anche Sonia, dopo essersi occupata di televisione per diversi anni (fino a diventare direttore dei programmi a Tele Montecarlo nel 2000) ha iniziato a produrre cinema con diversi film interessanti all’attivo, tra i quali “Miral” di Julian Schnabel, tratto dal libro dalla sua allora moglie, Rula Jebreal.

Sono arrivato all’appuntamento con la mia abituale puntualità friulana, alle 17:55. Sonia non era ancora arrivata e mi sono presentato a Franco Tatò che era in compagnia di una delle sue figlie. Non sapevano chi fossi ma mi hanno accolto bene e sono rimasto a conversare con loro in attesa della padrona di casa, che era rimasta un’ora indietro e pensava fossero ancora le 17:00.
Avevo sentito parlare molto di Franco Tatò quando era Amministratore Delegato dell’Enel (dal 1996 al 2002), ed era soprannominato “Kaiser Franz” per il rigore che aveva dimostrato nella sua volontà di risanamento dell’azienda.
Ne ho avuto subito un’ulteriore conferma.
Per rompere il ghiaccio e trovare un terreno comune, ho buttato lì la mia esperienza di lavoro per l’Enel con la produzione di un documentario nel 1994 che aveva un budget notevole.
“Quando c’era uno spreco vergognoso di denaro pubblico.” – ha commentato con ironia – Poi sono arrivato io.”
E’ andata meglio con Cardarelli, quando il discorso si è spostato sui suoi anni di formazione a Lodi. Nato nel 1932, a undici anni Franco Tatò ha avuto un incontro fondamentale con un insegnante che tra le altre cose aveva imposto ai suoi allievi, contro corrente, la traduzione dell’Odissea di Ettore Romagnoli (Zanichelli, 1923) rispetto a quella in versi del 1805 di Ippolito Pindemonte, all’epoca ancora utilizzata a tappeto in tutte le scuole del regno. Lo stesso insegnante, invece delle poesie di Pascoli, gli aveva fatto imparare a memoria quelle di Vincenzo Cardarelli… e lì forse ho guadagnato qualche punto, ricordando la citazione/omaggio che Tomasi di Lampedusa fa a Cardarelli nel Gattopardo.

Mentre sorseggiava un beverone di proteine, criticato dalla figlia assolutamente contraria a quel tipo di alimentazione, Franco Tatò ha iniziato improvvisamente a declamare Cardarelli, ma non con intento auto celebrativo… era un momento della sua dimensione mitologica privata che regalava alla figlia, e in quel caso anche a me che ho avuto la fortuna di capitare li al momento giusto. Quello scambio padre/figlia era molto bello e sincero. Lei ammetteva di non essere stata mai esposta alla poesia, di ignorare ci fosse Cardarelli, e si rammaricava che con tale ritardo il padre l’avesse stimolata con quei suoi lontani ricordi. Quello che mi ha sorpreso è la capacità di Franco Tatò nel declamare versi: uno stile asciutto ma partecipe, autorevole ma per niente aulico, molto intimo invece in quanto rivolto alla figlia che gli stava davanti. Bravissimo!
Il discorso è poi tornato ancora sulla grande lezione del suo insegnate delle medie che era riuscito a stimolarlo nella giusta direzione, dandogli la dimensione di elasticità e adattabilità che dovrebbero avere la cultura e l’insegnamento.
Mi ha fatto pensare a mio padre, laureato in fisica teorica, che mi aveva parlato di un suo insegnante di matematica del liceo e di quanto fosse stato fondamentale per la sua formazione. Se penso ai miei insegnanti del liceo non trovo nulla del genere. Solo più tardi, all’università, ho riconosciuto dei maestri: Jean Chirstensen, docente di storia della musica all’università di Louisville… Francesco Dal Co e Massimo Cacciari che ho seguito per un paio d’anni quando insegnavano rispettivamente storia dell’architettura ed estetica alla facoltà di architettura di Venezia.

Forse nell’arco di poche generazioni c’è stato un decadimento del livello degli insegnanti di medie e liceo, oppure mio padre e Franco sono stati più fortunati di me.
Il discorso è poi passato alla Divina Commedia che da ragazzo aveva imparato a memoria integralmente… ma ora si ricorda solo qualche frammento. Ed ecco che nel bel mezzo di una declamazione dantesca, Sonia fa il suo ingresso in casa…

Ci siamo fermati un attimo a ricordare il comune amico che ci ha lasciati (il “dost” che abbiamo condiviso) e dopo qualche informazione di carattere generale mi ha portato a vedere l’opera di Daniele nell’ingresso, accendendo le luci.
Ci vuole del coraggio per osare un simile azzardo e ospitare un’opera così invasiva nel proprio ingresso di casa! Mi sono avvicinato, spostandomi nella stanza per osservarla bene dalle diverse angolazioni.
“E’ stata lei…!” ha puntato il dito Franco.
A quanto pare, approfittando di una sua assenza per lavoro, lo aveva messo davanti al fatto compiuto, facendo installare l’opera dove lui aveva pensato di sistemare una parte della sua grande biblioteca.
Conosco bene il lavoro del mio amico friulano, ma quello che ha fatto in quello spazio “privato” è qualcosa di completamente nuovo.
Ho lavorato con lui la prima volta nel marzo del 2008, girando una breve documentario su una sua grande video installazione all’hangar Bicocca (“Fatica n° 16”) realizzata in collaborazione con Magazzino d’Arte Moderna di Roma e curata da Federica Schiavo. In quello spazio enorme, prima della ristrutturazione dell’hangar (100 x 30 metri, 8 metri di altezza), aveva utilizzato sette videoproiettori sincronizzati che con la necessaria complicità del suono davano per una frazione di secondo la sensazione di una dilatazione dello spazio, giocando con lo sfalsamento della percezione dei nostri sensi.

Il lavoro a casa di Sonia e Franco invece, è un oggetto fisso e inanimato che stranamente riesce a dare una percezione analoga e persistente, giocando con la proporzione sballata del volume in relazione con lo spazio che lo ospita.
E’ una “porta gigante” che seguendo una traiettoria quasi diagonale, taglia la stanza a metà, con spavalderia, osando un gesto estremo che sembra non temere conseguenze, che non si preoccupa in alcun modo di avere una funzionalità, un senso pratico. Quel movimento aggressivo e inaspettato è una sorpresa per chiunque entri in casa. Il titolo dell’opera rende l’idea: “Interazioni d’urto n° 1”

Questo lavoro, forse più degli altri, è in linea con il carattere di Daniele che a volte appare totalmente privo di diplomazia e pur di chiarire il suo punto di vista arriva a essere quasi aggressivo, parlando senza filtri, lasciando le persone che lo ascoltano perplesse, a volte offese. Mi è capitato più volte di assistere a queste dinamiche che mi divertono molto, che per me sono una conferma del valore della persona e del suo lavoro. In un mondo pieno di lacchè che non si vogliono esporre, che si muovono timidamente per non perdere posizioni, Daniele va avanti con spavalderia e coraggio, rischiando sempre, con candore e onestà intellettuale.

Come per il film di Asghar Farhadi che fa esplodere i sentimenti dei protagonisti della storia nell’immobilità di una stanza, ecco un altro movimento tellurico interiore che annulla l’inerzia dell’oggetto e gli dà vita con una dinamica misteriosa, troppo complessa per essere sviscerata razionalmente, ma il cui potente effetto percettivo e innegabile. La grande “porta magica” vibra come un diapason, ma è come se lo facesse in una dimensione parallela di cui percepiamo solo l’eco, in contrasto con la nostra lettura razionale.

Sarebbe certamente piaciuta a Jim Morrison, che scelse per la sua band il nome “The Doors”, proprio pensando a “The doors of Perception” di Aldous Huxley… e a Dino Buzzati, che nella sua Milano, raccontava spesso di porte misteriose che permettevano il passaggio da una dimensione all’altra.

E’ bello sapere che a casa di Sonia e Franco esiste uno di questi “passaggi segreti”, risultato del felice incontro tra la visione di un artista e la volontà sperimentale, l’apertura mentale di chi gli ha dato fiducia, accogliendo il mistero di una creatività estranea tra la mura della propria casa.
Ferdinando Vicentini Orgnani