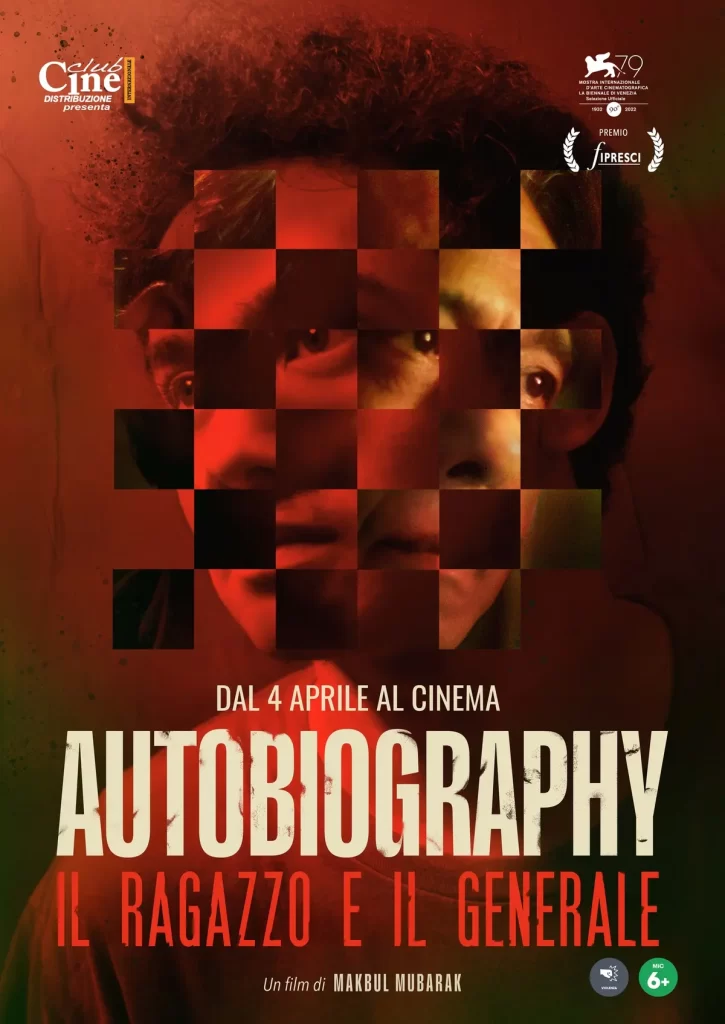L’ultima fatica di Mel Gibson in veste di regista e, almeno in parte, come produttore, narra le vicende del primo obbiettore di coscienza americano ad essere stato decorato con la medaglia d’onore del Congresso degli Stati Uniti. Desmond Doss, interpretato da Andrew Garfield, è il figlio di un veterano della prima guerra mondiale (Hugo Weavings). E’ un padre sconvolto e trasformato dall’esperienza bellica che si rifugia nell’alcol e che indulge alla violenza contro la moglie ed i due figli. Per contrasto il giovane Desmond matura una profonda fede che fa il paio con il rifiuto per le armi, che non gli impediranno però di arruolarsi volontario per servire il proprio paese. Ma il suo peculiare sistema di valori gli crea evidenti problemi con l’esercito apparentemente incapace di gestire una così strana e tenace risoluzione. Tant’è che quando viene il momento di partire per la guerra siamo già al maggio 1945 e la guerra è quasi bella che finita (grazie a quelli che sparavano davvero).

Dal lontano 1993 con “L’uomo senza volto” sino all’ormai non tanto recente “Apocalypto” ho trovato sempre elementi di originalità nei film di Mel Gibson, che mostra un talento più poliedrico quando dirige che non quando recita. Nel suo ultimo lavoro invece l’originalità sembra essere la prima vittima che nemmeno l’eroico Desmond Doss è riuscito a salvare. Se da un lato è da apprezzare la ricerca di una dimensione eroica differente per un’America sempre ancora molto giovane che sia un’alternativa al solito buon soldato cui ci ha abituato negli anni la cinematografia americana, tra cui ricordiamo almeno tre esempi con Oliver Stone (“Platoon“), Steven Spielberg (“Salvate il Soldato Ryan“) e Brian De Palma (“Victim of Wars“); dall’altro l’esperimento pacifista cozza vistosamente con una realtà di guerre quasi ininterrottamente combattute dagli Stati Uniti in tutto il mondo dalla seconda guerra mondiale ai giorni nostri, delle quali molte scatenate dagli stessi americani.

Il dramma delle perdite è poi sintomatico della cultura americana i cui media ne hanno da sempre amplificato l’impatto emotivo nell’opinione publica. Si pensi che gli americani ebbero nella battaglia di Okinawa, di cui Hacksaw Bridge è un episodio, 4.000 caduti contro i 110.000 dei giapponesi. Nella sola battaglia di Verdun durante la prima guerra mondiale francesi e tedeschi ebbero complessivamente più caduti di quanti quelli dubiti dall’intero esercito americano nel corso della prima e seconda guerra mondiale assieme. Gibson aiuta gli americani a guardare la guerra con il binocolo all’incontrario, che ingigantisce ciò che li riguarda e sminuisce ciò che attiene al nemico (di ben altra caratura il dittico di Clint Eastwood sulla guerra nel Pacifico) .

Dal punto di vista narrativo il film è nettamente diviso in due parti, alla moda di “Full metal Jacket” di Stanley Kubrick, e ciascuna rappresenta un catalogo di citazioni che non lasciano spazio ad alcuna proposizione originale. Ci si ritrova “Pearl Harbour” nell’infermiera Dorothy (Teresa Palmer), fidanzata e poi moglie di Desmond; c’è il sergente duro ma umano di “Gunny“, interpretato da un convincente Vince Vaughan; c’è la corte marziale di “Victim Of Wars” , qui un po’ da operetta con tanto di interruzione del papà con uniforme e agghindato di medaglie che da ubriacone si trasforma in un fine oratore.

Nella seconda parte c’è un po’ di “La Sottile Linea Rossa” di Terrence Malick (ma senza la medesima maestria delle immagini), evidente nella sfilata di macilenti camerati mentre tornano dalla prima linea con in testa un carro Sherman che rivedremo più volte nel film (visto che ormai lo avevano noleggiato) e che non si capisce a cosa possa servire dal momento che la scarpata da scalare è così ripida che bisogna arrampicarsi su una scala di corda; ci sono scene di combattimento cruente e ravvicinate come in “Windtalkers“, ferite allucinanti e corpi smembrati come in “Salvate il soldato Ryan” (ma senza un montaggio così perfettamente serrato); c’è la richiesta di bombardare la propria posizione perché l’attacco non è più arginabile come avviene in “Platoon“; non può mancare “Il giorno più lungo” rievocato dal capitano Glover (Sam Worthington) che nonostante gli sia rimasta solo una manciata di uomini decide di salire nuovamente sulla scala di corda per conquistare il crinale e che se ne esce con un “Andiamo a finire il lavoro” che è roba da alzarsi e chiedere il rimborso del biglietto.

Insomma ci sono tutti i film già visti, l’unico che manca è proprio quello di Gibson. Trascorsi 131 minuti di cui metà a fare su e giù da una scala di corda che non si sa chi ha mai messo (forse una cortesia degli stessi giapponesi), alla fine il film finisce senza spiegare perché mai con meno uomini e più provati sono riusciti a fare ciò che avevano fallito quando erano di più e ancora pimpanti.

Anche il messaggio veicolato per cui esistono eroi senza macchia che combattono senza il fucile non regge ad un esame logico per cui se non ci fossero quelli con il fucile (in un rapporto astronomicamente più elevato tocca dire), non ci sarebbero obbiettori di coscienza a poter fare gesta mirabolanti. Peccato perché tutto il cast recita in maniera impeccabile e sorprende piacevolmente Garfield, a suo agio in questo film tanto come in Spider-man e come prelato gesuita. Il problema non sono quindi gli attori ma pare circoscritto alla scrittura ed alla regia. Per cui l’unico vero elemento da salvare è un’indicazione pratica, ovvero che se siete dei giapponesi e dovete respingere uno sbarco nemico è opportuno tagliare la scala di corda che pende dalla scogliera.