La marchesa De Luna possiede una piantagione di tabacco e cinquantaquattro braccianti che la coltivano senza ricevere nulla in cambio eccetto la possibilità di vivere su quei terreni, in fatiscenti catapecchie senza elettricità. In mezzo alla piccola comunità agricola, si muove Lazzaro, ragazzo buono e generoso, sfruttato dagli stessi compagni con i quali condivide la condizione di “schiavitù”.

Il paesaggio rurale torna ad essere protagonista nella terza pellicola di Alice Rohrwacher. Come per Le Meraviglie(2014), la storia è ambientata in un territorio vibrante di echi antichi: dalle novelle boccaccesche alle visioni bucoliche di Paolo e Vittorio Taviani –”Fiorile” (1993).
Pur conservando il tocco “meraviglioso” dei fratelli toscani, l’autrice mette in pratica la lezione appresa dai maestri del neorealismo – la scrittura “libera” (da meri vincoli narrativi) zavattiniana –, lasciando che lo sguardo dello spettatore girovaghi tra lo squallore dei ruderi dell’Inviolata e una periferia urbana degradata. Una sorta di realismo magico che non può non ricordare le atmosfere (altrettanto livide e sgranate quanto surreali) della cinematografia sudamericana contemporanea – “Neruda” di Pablo Larrain (2017).
Lazzaro feliceè un’opera unica, perché espressione della visone eccentrica (nel suo significato etimologico) del cinema, e del mondo, della cineasta fiorentina. Un film che non trovando, o cercando, il proprio centro (narrativo) è costretto al nomadismo. Un racconto senza compromessi – vincitore del Prix de la mise en scènea Cannes – che nella sua assoluta libertà tocca vette elevatissime di lirismo – la parabola del lupo e dell’eremita.

In scorci biblici che cristallizzano lo spazio-tempo in una Galilea postmoderna – El cristo ciego di Christopher Murray (2016) –, lo sguardo stupefatto di Adriano Tardiolo ci interroga sulla natura della felicità. Lazzaro felice – lo è, non deve affannarsi per diventarlo – perché puro, innocente, buono… ma anche ignorante, nel senso attribuitogli dalla marchesa De Luna, che ignora, cioè, le condizioni in cui (soprav)vive. Il Vecchio Testamento insegna: i tormenti dell’uomo iniziarono con la mela colta dall’albero della conoscenza, se non avessimo assaggiato quel frutto proibito saremmo potuti essere felici, come Lazzaro (il buon selvaggio rousseauiano).

Oltre a ciò, c’è un’altra domanda che alimenta il fuoco del film: che fine ha fatto la bontà?
Non esiste più; o almeno, si è estinta quell’espressione di cui Lazzaro è rappresentante: quella per cui versare una lacrima per un amico colpevole – il “mezzo fratello” Tancredi -; quella per la quale aiutare chi non lo merita – il custode di galline -; quella che spinge al sacrificio di sé.
E questo è evidente nella parabola del protagonista. Nella seconda parte del lungometraggio (speculare alla prima), infatti, il giovane uomo, non più Corpo celeste (2011) ma corpo umano votato al martirio, risorgere – come nel Nuovo Testamento – solo per morire di nuovo, massacrato dalle botte dei clienti della banca – che si sfogano su di lui come i contadini dell’Inviolata: là vessati dalla marchesa, qui da un istituto di credito (metafora della crisi economica) –; ricompensa per chiunque, oggi, viva sotto il segno della bontà.
Alessio Romagnoli



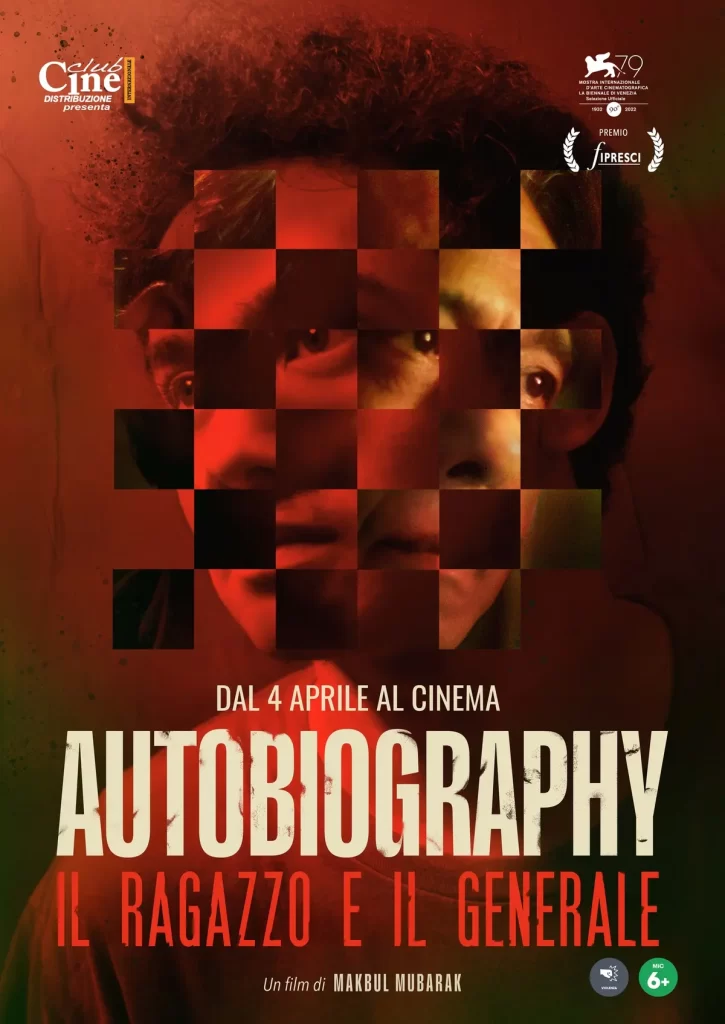


No comment yet, add your voice below!