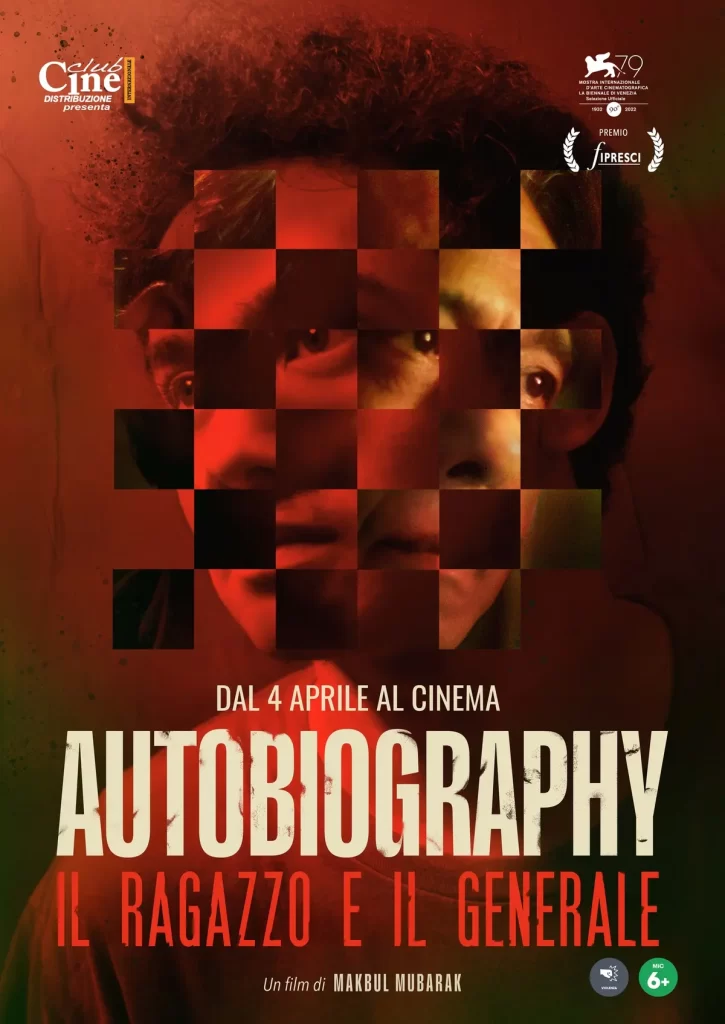“Grieved, she recounts how, by mischance,
Puir pussy’s forced a’ night to prance
Wi’ fairies, wha in thousands dance
Upon the green,
Or sail wi’ witches over to France
At Hallowe’en“
John Mayne,Hallowe’en (1780)

“La notte delle streghe” (1978) si avvicina; no, tranquilli, il vostro giugulare è al sicuro, Michael Myers è ancora rinchiuso nel manicomio di Smith’s Grove – almeno fino al prossimo 25 ottobre, quando in Italia uscirà in sala l’ultimo capitolo della saga dedicata ai massacri dell’UomoNero (“Halloween” di David Gordon Green) -, ad appressarsi, invece, è la ricorrenza celtica più diffusa al mondo, Halloween.
Per trascorrere un “Tranquillo weekend di paura” (1972) – visto il lungo “ponte” che si prospetta per la “festa dei morti” -, ecco a voi una breve lista di quattro film dell’orrore – “rigorose” scelte di gusto (il mio) -, per spaventarsi e divertirsi in compagnia… o da soli, per i più coraggiosi.
Chiudete il libro di Mayne e spaparanzatevi sul divano; affondate una mano nei pop-corn e allo scoccar della mezzanotte – del 31 ottobre s’intende, ovviamente – schiacciate play.
Scary Halloween!
Al lettore (im)paziente…
Ogni elenco (cinematografico) che si rispetti non può che iniziare con un lungometraggio d’antan, una vecchia pellicola, con cui un recensore ostenta le proprie conoscenze – enciclopediche, senza dubbio. Ahimè, anch’io non posso sottrarmi… “Oh, vanità dell’arte!”. Le abitudini (critiche) sono dure a morire, “trappole di cristallo” (1988): senza accorgercene, siamo già stati catturati.

- The Wicker Man– L’uomo di vimini di Robin Hardy, GBR, 1973
“Tantum religio potuit suadere malorum”
Lucrezio, De rerum natura
Un mostro (sacro) del brivido, Christopher Lee – da “Dracula il vampiro” (1958) a “La maschera di Frankenstein” (1957), entrambi diretti da Terence Fisher, “maestranza” gotica al servizio della Hammer Film-, un totem dell’horror, dicevo, per un classico del genere.
Rowan Morrison è scomparsa da una remota isola delle Ebridi. Dalla terra ferma, il sergente Howie si mette sulle tracce della bambina, ma la comunità locale, guidata dall’eccentrico Lord Summerisle (Christopher Lee, appunto), non sembra voler collaborare. Che cosa provoca la loro diffidenza? Potrebbero essere le misteriose usanze pagane del villaggio? Oppure i baccanali orgiastici sulla spiaggia? O è forse il sacrificio programmato per Calendimaggio? Questa volta, però, l’olocausto di un agnello non sarà sufficiente a placare l’ira degli dei, perché solamente il sangue umano potrà benedire l’imminente festa del raccolto.
Qualche granello di polvere – vezzi di un cinema d’altri tempi (l’invadente colonna sonora) – non può offuscare il fascino del film di Robin Hardy. In un paesaggio mozzafiato – gli arcipelaghi scozzesi -, si scontrano due filosofie di vita: il puritanesimo bacchettone della Gran Bretagna anni ’70 e la sensualità sfrenata di una società (segreta) estranea ai costumi dell’epoca – incarnazione sfacciata della liberazione sessuale dei figli dei Beatles e degli Stones. Atmosfere suggestive – tra capanne di pescatori e stornelli triviali -, humour britannico e un finale “incandescente”; una carnevalata alla Ensor – “Skeletons Fighting for The Body of a Hanged Man”(1891) – che mette a confronto cristianesimo e paganesimo celtico, sacrificio rituale – di Rowan, vittima (per nulla) innocente – e martirio per la fede – di Howie, cavaliere di Cristo costretto a subire il supplizio degli antichi Galli -, “dando alle fiamme” le contraddizioni insite in ogni religione.

- The Blair Witch Project– Il mistero della strega di Blair di Daniel Myrick ed Eduardo Sanchez, USA, 1999
“The content of this painting is invisible; the character and dimension of the content are to be kept permanently secret, known only to the artist”
Mel Ramsden, Secret Painting

Caposaldo del found-footage horror – in grado di stabilirne le regole a quasi vent’anni dalla nascita (“Cannibal Holocaustdi” Ruggero Deodato, 1980). “Progetto” ambizioso e raro esemplare di trans-media storytelling: un immenso apparato paratestuale – dalle interviste a finti detective ai missing poster affissi sulle bacheche del campus universitario frequentato dai tre attori protagonisti -, un vasto corpus extra-diegetico quindi, che, durante la primissima proiezione del film, convertì l’impressione di realtà in illusione collettiva, persuadendo il pubblico in sala della veridicità degli eventi raccontati – il treno dei fratelli Lumiere è di nuovo in stazione! Una geniale trovata di marketing che celebrò il matrimonio tra una minuscola produzione indipendente e gli incassi multimilionari di un blockbuster.
Alla ricerca di prove sull’esistenza della strega di Blair, una troupe amatoriale di documentaristi si perde nei boschi del Maryland. Tutto qui, nient’altro.
Una pellicola “cieca” – le sequenze notturne sono illuminate approssimativamente, frammentando la percezione dei fatti -, “ieratica” – nella ripetizione ciclica dell’azione (il vagabondaggio dei
personaggi) -, “ipnotica” – dove sussurri, pianti e urla compongono una litania sonora che acuisce la tensione. Non solo, come in una “tela nera”, il visibile è annullato, eppure ciò non significa arrendersi all’insensato ma spalancare la porta dell’immaginazione. Così, mentre l’angoscia si autoalimenta, è possibile accorgersi delle somiglianze tra TBWP e il “Secret Painting” di Ramsden (di cui il primo sembra la trasposizione cinematografica). Infatti, l’opera dell’artista britannico – un quadro totalmente nero, affiancato dalle parole riportate nell’esergo- da una parte relega sullo sfondo la figura dello spettatore, ma dall’altra gli conferisce un potere inaudito, quello dell’interpretazione libera, un’attività creatrice il cui unico vincolo è la fantasia
Spente le luci, l’incipit del mockumemnteary ci ricorda che: “Nell’ottobre del 1994 tre studenti videoamatori scomparvero in un bosco nei pressi di Burkittsville, mentre stavano girando un documentario. Un anno dopo fu ritrovato il loro filmato”… bene, «adesso è il vostro turno», pare sfidarci il film, «siete voi gli sceneggiatori, scrivete la storia, inventate il resto: il limite sono i vostri incubi».
Alessio Romagnoli